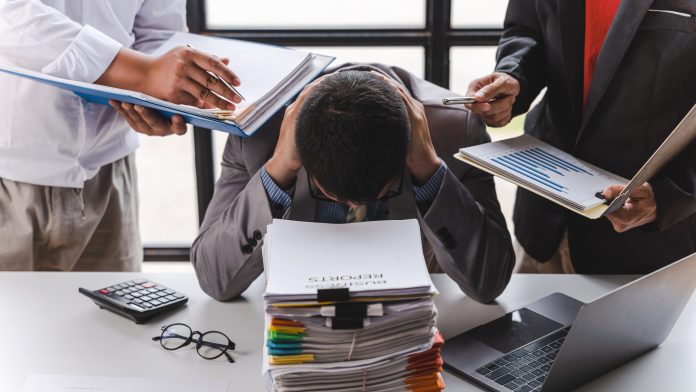La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 637 del 6 marzo 2023, ha stabilito che il datore, nella lettera con cui comunica il licenziamento al lavoratore, deve specificare la motivazione del licenziamento, mentre non è necessaria l’indicazione di tutti gli altri elementi posti alla base del provvedimento.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso di Sempronio, rilevava l’inammissibilità della domanda del lavoratore per tardività dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento.
Sempronio impugnava la decisione del giudice di prime cure, sostenendo l’illegittimità della stessa, specie nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili le domande relative al licenziamento, considerando erroneamente operante il termine di decadenza, senza tener conto della mancata comunicazione al dipendente dei motivi del recesso datoriale.
I giudici del gravame respingevano l’appello.
La Corte d’Appello di Roma richiamava consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento”.
Nella vicenda esaminata, il licenziamento di Sempronio risultava giustificato con una ragione oggettiva, dichiaratamente integrata dall’esigenza di ridurre il personale.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
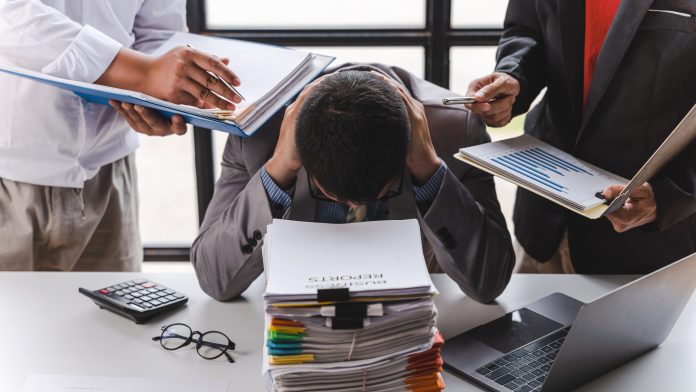
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6008/2023, si è pronunciata in tema di superlavoro.
Tizio conveniva in giudizio l’azienda datrice per domandare la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all'infarto del miocardio subito a causa del sottodimensionamento dell'organico che l'aveva costretto per diversi anni a pesanti ritmi e turni di lavoro.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda dell’attore, escludendo la responsabilità dell'azienda convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c., dal momento che la stessa non aveva il potere di aumentare l'organico e di assumere altri dipendenti.
I giudici del gravame respingevano l’appello.
A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, la quale dava ragione a Tizio.
Gli Ermellini specificavano che “Il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile”.
Secondo i giudici di legittimità, “Oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica … , ancor meno ciò può essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, è in sé dedotto un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche”.
La Suprema Corte sottolineava che i giudici di secondo grado avevano errato nel pretendere da Tizio l'indicazione di «ben determinate norme di sicurezza», essendo idonea e sufficiente a dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro la prova dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e tollerabile orario lavorativo.
Altresì, rimproverava alla Corte distrettuale l'inserimento del tema della mancanza di autonomia dell’azienda nella decisione di assumere altro personale nell'ambito della motivazione sul mancato assolvimento degli oneri di allegazione e di prova gravanti sul dipendente.
Pertanto, i giudici di piazza Cavour accoglievano il ricorso del lavoratore.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

Con l’ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell’appalto di manodopera è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione, la cui mancanza fa rientrare il negozio fra quelli vietati.
Nel caso in esame, alcuni lavoratori, addetti per anni ad un appalto, proponevano ricorso al Tribunale per sentirsi dichiarare la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente.
Mentre il giudice di prime cure rigettava le domande, i giudici del gravame ritenevano che tra le parti fosse esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le decorrenze per ciascun lavoratore specificate e con diritto all'inquadramento nella categoria E.
A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, la quale richiamava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L’appalto di manodopera vietato dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'articolo 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore. L'appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 del citato articolo 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Secondo gli Ermellini, in tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione, la cui mancanza, come avvenuto nella vicenda esaminata, non può che collocare il negozio tra quelli vietati.
Pertanto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato. (Cass. Civ. Sez. L., 02/03/2023, n. 6336)
Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia. (Cass. Civ. Sez. L., 19/01/2023, n. 1601)
Le regole dettate dall'art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento); ne deriva che lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Cass. Civ. Sez. L., 12/12/2022, n. 36188)
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ. (Cass. Civ. Sez. L., 28/07/2022, n. 23674)
Anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore - il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare l’atto di recesso - con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative. (Cass. Civ. Sez. L., 16/03/2022, n. 8628)
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3131 del 2 febbraio 2023, ha specificato che in caso di demansionamento illegittimo del dipendente, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno pari al 25% della retribuzione percepita nel periodo del demansionamento.
I giudici d’appello confermavano la sentenza di primo grado che, dopo aver accertato l’illegittimità del mutamento di mansioni disposto dalla società Gamma nei confronti di Sempronia, aveva condannato la datrice di lavoro a riassegnare la dipendente alle mansioni in precedenza svolte o ad altre equivalenti, nonché al risarcimento del danno quantificato in via equitativa in 12.290,75 euro, corrispondente al 25% della retribuzione all'epoca goduta per ciascun mese di demansionamento.
La società Gamma si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2103, comma 2, c.c. e dell'art. 41 Cost. censurando la sentenza impugnata in base alla considerazione che erano state esaminate circostanze non rilevanti ai fini della valutazione del rispetto della norma codicistica e che la Corte territoriale, in violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica, si era sostituita alla valutazione, spettante alla società, circa la complessiva utilità dell'operazione, come non consentito.
I giudici di piazza Cavour, nel ritenere la censura inammissibile, evidenziavano che l’art. 2103 c.c. contempla l’assegnazione del prestatore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale, soltanto qualora intervenga una modifica degli assetti organizzativi dell’azienda, incidente sulla posizione del lavoratore; contrariamente, si configura un demansionamento illegittimo per il quale il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno.
Per gli Ermellini, nella vicenda esaminata, i giudici del gravame, piuttosto che sostituirsi alla società nella valutazione di opportunità e convenienza della riorganizzazione, in violazione del principio di libertà economica di cui all'art. 41 Cost., si erano limitati a rilevare l’insussistenza in fatto dei presupposti legali per il demansionamento di Sempronia, senza in alcun modo argomentare circa il diritto o meno della società di procedere alla riorganizzazione.
Pertanto, il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'