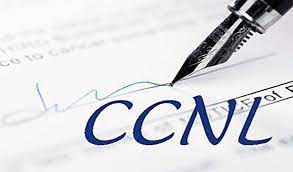Qualora intervenga una declaratoria giudiziale di nullità del trasferimento di azienda, tutte le vicende che riguardano il rapporto di mero fatto instaurato fra il prestatore e la cessionaria, comprese quelle risolutive, non producono alcun effetto sulla cedente, la quale resta gravata dei propri obblighi retributivi.
Detto principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39148/2021.
Nella vicenda in esame, Tizio impugnava la sentenza del Tribunale che, accogliendo l'opposizione della società datrice Alfa, aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare al lavoratore la somma di euro 28.263,18 per retribuzioni non corrispostegli dall'ottobre 2013 al luglio 2014, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla società Beta ove lo stesso era occupato, con ordine di ripristino del rapporto.
Il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, poiché Tizio aveva accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la cessionaria in data 31 maggio 2011, con ritenuta conseguente estinzione dell'unico rapporto con la cedente e solo di fatto proseguito con la cessionaria.
La Corte territoriale accertava e riteneva che la transazione in questione non riguardasse affatto la società Alfa, e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti di Tizio per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda.
A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale rigettava il ricorso.
In particolare, gli Ermellini precisavano che “in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.
Inoltre, “In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

Con l’ordinanza n. 74 del 4 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contratti collettivi post-corporativi di lavoro, soffermandosi in particolar modo sulla loro efficacia.
Nel dettaglio, il Tribunale Supremo ha affermato che “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”.
Di conseguenza, qualora, per la decisione della causa, una delle parti faccia riferimento ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a detto contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, “il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
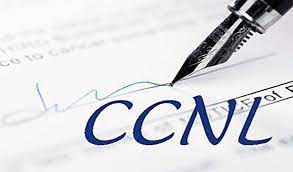
Un’azienda che esercita una specifica attività può applicare un contratto collettivo di un diverso settore?
L’art. 2070 c.c. dispone che “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”.
La norma in questione è strettamente connessa all’abrogato ordinamento corporativo e risulta essere incompatibile con un sistema basato sulla libera autodeterminazione sindacale.
Il primo comma dell’art. 2070 c.c. non opera nei confronti della contrattazione collettiva di diritto comune, in quanto quest’ultima ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano aderito al contratto.
In tal senso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 1813/2010, ha stabilito che “nell’ordinamento attuale, venuto meno il contenuto normativo dell’art. 2070 c.c., vige il principio per il quale, se il datore di lavoro non aderisce al sindacato imprenditoriale firmatario dell’accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l’imprenditore stesso di applicare il contratto corrispondente all’effettiva attività economica esercitata”.
Nell’ipotesi in cui il contratto individuale di lavoro sia regolato da un CCNL che si riferisca ad un settore diverso da quello dell’attività svolta dal datore, il dipendente non può pretendere l’applicazione di un CCNL diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato in ragione dell’appartenenza all’organizzazione sindacale stipulante.
In tali casi, il prestatore di lavoro può solo richiamare la diversa disciplina collettiva come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal CCNL applicato.
Ciò è confermato da una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicato alcun contratto collettivo, e sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass., sent. n. 10002/2000).
Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, all'individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro si deve procedere mediante l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla eventuale protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo determinato.
Con la sentenza n. 5596 del 14 aprile 2001, i giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, essendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di detta condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole.
Il semplice richiamo alle tabelle salariali di un CCNL, o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL, abbia applicato solo alcune clausole di detto contratto, non basta per concretizzare un’adesione implicita, tale da rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

I contratti collettivi si articolano su due livelli:
• nazionale (il cosiddetto CCNL);
• territoriale/aziendale.
Il contratto collettivo nazionale (CCNL) è quello che, oltre a fissare i trattamenti economici e normativi per i lavoratori di uno specifico settore, definisce le materie che sono invece delegate alla contrattazione aziendale.
Con il contratto collettivo aziendale o territoriale vengono disciplinate tutte le questioni di carattere economico e normativo che possono sorgere in ambito aziendale. Esso permette di adattare la disciplina dei rapporti individuali agli specifici aspetti di quella che è la singola realtà locale.
Oltre a quelli appena descritti, viene poi in rilievo un terzo livello contrattuale nel quale trovano spazio i cosiddetti accordi interconfederali, che hanno la funzione di stabilire le regole generali della contrattazione.
Il dibattito sul rapporto tra i contratti collettivi di diverso livello è da sempre caratterizzato da importanti riflessioni dottrinali, nonché da un’ampia produzione giurisprudenziale.
Difatti, fra contratto nazionale e contratto aziendale non vi è un rapporto gerarchico, come tra contratto collettivo e contratto individuale, bensì un rapporto di pari ordinazione, non essendoci una norma di legge che disciplina i rapporti fra i due livelli contrattuali.
Il rapporto fra contratto aziendale e contratto nazionale, in assenza di una norma di legge volta a regolare i rapporti tra i due livelli contrattuali, ha fatto sorgere il problema del concorso-conflitto tra fonti di diverso rango nella regolamentazione di uno stesso istituto.
A dare una soluzione a tale problema sono intervenute negli anni dottrina e giurisprudenza.
In particolare, la giurisprudenza, dopo aver stabilito che al conflitto fra contratti collettivi di diverso livello non potesse trovare applicazione l’art. 2077 c.c. (principio del favor prestatoris, che riguarda esclusivamente il rapporto tra disciplina dettata dal contratto collettivo e contratto individuale di lavoro) e neppure il criterio gerarchico, secondo cui il livello decentrato sarebbe subordinato a quello nazionale, diede spazio, anche se per un breve lasso di tempo, al criterio cronologico. Tale orientamento, faceva prevalere l’ultimo contratto, nazionale o aziendale che fosse, su quello precedente, rappresentando, in quanto successivo, la più attendibile manifestazione di volontà delle parti interessate.
Successivamente, abbandonato anche il criterio cronologico, la giurisprudenza finì per accogliere il criterio della specialità, cioè la prevalenza del contratto aziendale, sebbene peggiorativo, in quanto più vicino agli interessi da regolare.
Solo verso la seconda metà degli anni ottanta la giurisprudenza stabilì che il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello dovesse essere regolato dal principio di autonomia. In tal modo venne attribuita maggiore rilevanza alla volontà delle parti, offrendo alle diverse regolamentazioni della contrattazione collettiva pari dignità e forza ugualmente vincolante.
In altre parole, “Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività, sicché i contratti territoriali possono derogare anche in peius il ccnl” (Cass., sent. n. 17421/2018).
Dunque, “Il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati” (Cass., sent. n. 9052/2006).
L’Accordo Interconfederale sottoscritto nel 2011 da CGIL, CISL, UIL e Confindustria ha consentito ai contratti collettivi aziendali di poter realizzare, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nei limiti e secondo le procedure previste da questi ultimi, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle r.s.u. o dalle r.s.a. che, singolarmente o assieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe. Ciò ha permesso al contratto collettivo aziendale di poter, in caso di deroga, regolare una materia stabilendo condizioni peggiorative rispetto a quelle già previste dal contratto collettivo nazionale.
L’Accordo Interconfederale del 2011 ha, dunque, promosso lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello.
Altresì, è doveroso annoverare l’art. 8 d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, rubricato «sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità», che consente ai contratti aziendali o territoriali, sottoscritti da particolari soggetti e a specifiche condizioni, di regolare determinate materie indicate dalla legge con due effetti del tutto singolari:
• efficacia nei confronti di tutti i prestatori di lavoro interessati;
• possibilità di derogare, oltre che ai contratti nazionali, anche a norme di legge, con i soli limiti del rispetto della Costituzione e dei vincoli che derivano dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

Con l’ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a provare che, al momento del licenziamento del lavoratore, non vi fosse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti.
Tizia domandava di essere ammessa al passivo del fallimento della società Alfa per crediti derivanti dal proprio rapporto di lavoro subordinato con la predetta società: crediti ammontanti a complessivi euro 56.098,85 e riguardanti, oltre il TFR, le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla dichiarazione di fallimento, e ciò a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 3 legge n. 300/1970, nonché per quanto previsto, sempre a titolo risarcitorio, dallo stesso art. 18, comma 4.
Il giudice delegato ammetteva il solo credito relativo al trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Roma respingeva con decreto l’opposizione allo stato passivo proposta da Tizia, rilevando che il licenziamento dell'istante, motivato dalla necessità di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita, fosse legittimo.
In ordine alla contestata sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, il giudice dell'opposizione osservava che la società fallita si era determinata alla risoluzione del rapporto di lavoro per la circostanza, confermata testimonialmente, della soppressione del posto di visual; in ordine, invece, all'onere, gravante sulla datrice di lavoro, di provare di non aver potuto adibire la dipendente ad una diversa mansione, il giudice capitolino osservava che la fallita aveva rinnovato alla ricorrente la proposta, già formulata in sede conciliativa, di destinare la stessa all'incarico di addetta alla vendita, proposta che non aveva avuto seguito.
Tizia si rivolgeva alla Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, richiamava consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repéchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale”, e sottolineava “l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento”.
Secondo gli Ermellini, il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo il licenziamento intimato si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del lavoratore all'epoca del licenziamento stesso; questo può ritenersi legittimo ove la determinazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia motivata dall'impossibilità di destinare il prestatore di lavoro a mansioni diverse, situazione che, per condizionare il valido esercizio del diritto potestativo del datore, deve evidentemente sussistere nel momento in cui è espressa la volontà di recedere, e non in un momento successivo.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'