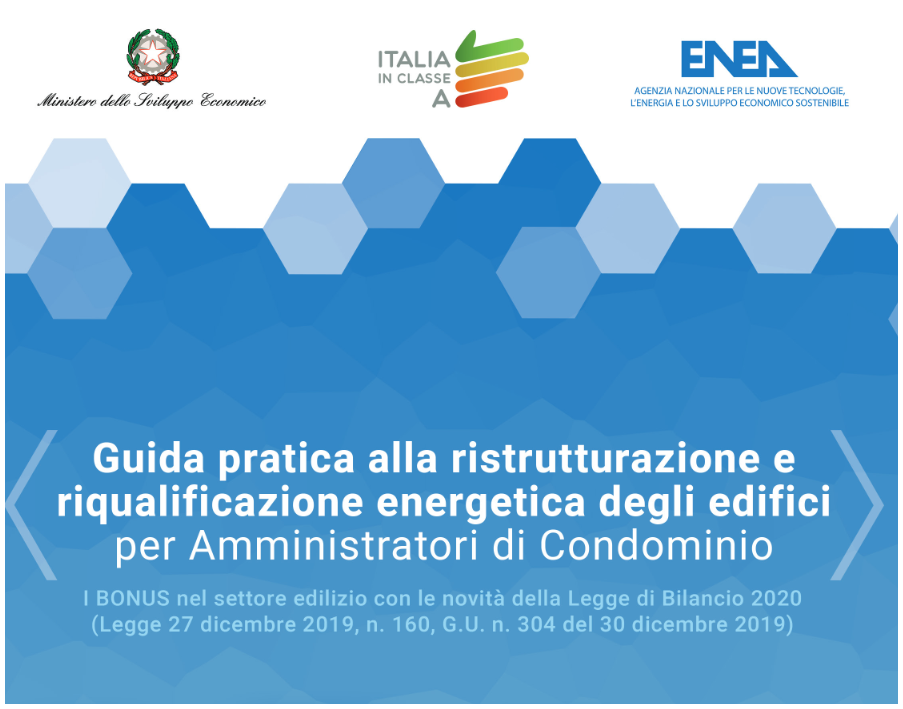Dieci piani di altezza, oltre 16.500 metri quadri esclusivamente dedicati a laboratori per la ricerca scientifica e 3.000 metri quadri di terrazze e coperture verdi: sono solo alcune delle caratteristiche del progetto del nuovo edificio di Human Technopole, l'istituto italiano di ricerca per le scienze della vita, situato a Milano nel cuore di MIND Milano Innovation District. L'edificio sarà la sede principale dei suoi laboratori scientifici e sarà al centro del Campus Human Technopole, cioè l’intera area del centro di ricerca, area in cui il nuovo edificio rappresenterà il nucleo centrale.
Lo studio di architettura Piuarch ha vinto il concorso internazionale di Human Technopole per l’ideazione dell’edificio sostenibile e del Campus di Fondazione Human Technopole e Arexpo. Lo studio milanese ha contribuito a numerosi grandi interventi di riqualificazione sul territorio milanese in aree quali: il Mecenate District e Porta Nuova. Per la realizzazione del progetto è atteso un investimento fino a 94,5 milioni di euro. Il Campus Human Technopole avrà una superficie di oltre 11.000 mq, all'interno della quale sono compresi anche i fabbricati attualmente già presenti, cioè Palazzo Italia, edificio iconico di Expo Milano 2015, il Padiglione Nord e il Padiglione Sud. Il progetto definisce come verranno sviluppate le zone di connessione, le pertinenze del nuovo building e i collegamenti con le aree esterne. Al suo interno sorgerà l'edificio che svilupperà una superficie complessiva di 35.000 metri quadrati e sarà alto, nel suo punto più elevato, 61 metri. Vi troveranno posto laboratori di biochimica e biologia molecolare, strumentazioni scientifiche d'avanguardia e fino a 800 postazioni di lavoro per ricercatori. Inoltre, saranno disponibili ampi spazi comuni, sale riunioni e aule per eventi e corsi di formazione.
Il nuovo edificio sarà costituito da due volumi funzionali e flessibili, che si svilupperanno intorno al Common Ground. Questo sarà il punto focale da cui si genera l’intera costruzione. Uno spazio centrale che sarà il cuore dell’edificio sia per la sua collocazione che per la sua funzione. Sarà infatti centro di snodo delle attività attorno al quale si distribuiscono i laboratori e gli uffici in due diversi volumi funzionali e flessibili e sarà caratterizzato da un piano terra in parte aperto e in parte vetrato.
I piani dal primo al nono saranno dedicati ai laboratori e agli uffici amministrativi. Mentre all’ultimo piano saranno ospitate zone ristoro, aule per attività formativa, sale riunioni di rappresentanza, uffici dirigenziali e le terrazze con diretto accesso alla copertura verde accessibile. Il tutto in un progetto integrato di edilizia sostenibile, che comprende: falde asimmetriche ed una sequenza di terrazze verdi ,un grande impianto fotovoltaico ed un sistema di copertura che permette un corretto controllo delle acque e contribuisce alla produzione di energia rinnovabile.
A collaborare con Piuarch saranno per il progetto Strutturale 3TI Italia, per quello impiantistico Seingim, per le infrastrutture J+S ed infine per il progetto urbano Archimi.

Una riflessione su cambiamenti dei consumi ai tempi del Coronavirus e sul futuro dell’abitare in chiave green
Presentato il 9 aprile in diretta su Facebook, a circa un mese dall’inizio delle misure di distanziamento sociale, il Dossier “Pandemia e sfide green del nostro tempo”. La web conference organizzata dal Green City Network e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in partnership con Ecomondo – Key Energy, ha aperto una riflessione su come gestire le nostre abitazioni, gli spazi intermedi e le nostre città dopo la pandemia. L’emergenza sanitaria in atto, infatti, sta sconvolgendo abitudini e stili di vita, causando una riduzione delle emissioni di gas serra, del traffico e mettendo in discussione modelli di consumo e di gestione dei rifiuti, dimostrando, tra le altre cose, che il tema del cambiamento climatico è strettamente connesso alle attività umane.
Questo periodo così difficile può essere quindi un’occasione per ripensare gli stili di vita e la gestione delle città in chiave green. La pandemia apre anche una riflessione su come ripensare le abitazioni e gli spazi intermedi (terrazzi, balconi, giardini condominiali ecc). Sul tema si sono confrontati Fabrizio Tucci, Professore della Sapienza di Roma e Coordinatore del Gruppo Internazionale di Esperti del Green City Network, affiancato da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo Sostenibile.
“Durante questa pandemia i consumi sono calati, l’attenzione sui consumi alimentari è cresciuta – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – ma dopo si tornerà al punto di partenza precedente, come se niente fosse accaduto, o avremo fatto qualche passo avanti per capire meglio le sfide del nostro tempo? Di quanto siano importanti e delicati i consumi alimentari, caratterizzati da alti sprechi e alti impatti e come la quantità di materiali che consumiamo sia enormemente cresciuta e ormai insostenibile. Stiamo avendo difficoltà nella gestione dei rifiuti e nel riciclo. Vi presteremo maggiore attenzione e trarremo una spinta maggiore per l’economia circolare, o metteremo in crisi i passi avanti compiuti prima della pandemia? Le emissioni di gas serra stanno calando, ma non dobbiamo trascurare la crisi climatica e le misure di decarbonizzazione perché dopo la crisi le emissioni torneranno a crescere se non si cambia. Il traffico in città è crollato, ma dopo riprenderà come prima o possiamo riflettere su come rendere la nostra mobilità nelle città meno inquinante e meno congestionata?”
“Probabilmente, anche attenuata o passata l’emergenza – ha detto Fabrizio Tucci, Professore ordinario della Sapienza Università di Roma e Coordinatore del Gruppo internazionale degli esperti del Green City Network – rimarrà intaccato e mutato nella sua natura e nelle sue modalità il modo di vivere ed “abitare”. Potremmo vivere questo incredibile periodo di forzata sperimentazione collettiva come occasione da cogliere per decidere di produrre nuove forme e nuovi spazi dell’Abitare, migliori per la collettività, più giusti e più inclusivi per le fasce più deboli, e più in linea con gli obiettivi propri di quello che definiamo green city approach”.
La riduzione delle emissioni dovute alla chiusura delle attività produttive, di industrie e servizi, e del trasporto, prevedibilmente non durerà dopo la crisi e non dovrebbe portare a sottovalutare l’impegno necessario e di lungo termine per contrastare il riscaldamento globale. Il trend delle emissioni globali, prima della pandemia da coronavirus era ben lontano dalla drastica riduzione necessaria prevista dall’Accordo di Parigi del 2015. In questo quadro la decarbonizzazione del settore civile resta una priorità. I consumi medi di una abitazione italiana normalizzati rispetto alle condizioni climatiche medie europee, sono alti, 1,91 tep/anno, contro, ad esempio, i 1,66 tep/anno della Germania. Nel dossier vengono proposte buone pratiche green nel settore residenziale per contrastare i cambiamenti climatici, aumentando l’efficienza e riducendo i consumi di energia, aumentando la produzione e l’uso nel settore residenziale delle fonti rinnovabili per elettricità e usi termici.
Per quanto riguarda i trasporti, si dovrà evitare che a crisi finita si ritorni al traffico inquinante delle nostre città. Sarà importante aprire una riflessione sulla modifica del modello di mobilità urbana dopo il Coronavirus. Le misure di confinamento spingono anche a riflettere sui fattori che determinano le scelte di mobilità, come ad esempio l’utilità dello spostamento, la scelta tra diverse possibili modalità in base all’efficienza, le alternative allo spostamento. Aver dovuto limitare il raggio di azione a qualche centinaio di metri intorno alla propria abitazione ha fortemente ridotto il ricorso all’auto, interrompendo un’abitudine. Il dossier indica anche buone pratiche green per rendere più sostenibile la mobilità nelle città, per ridurre gli spostamenti non necessari, per ridurre l’uso dell’auto nelle città e per promuovere l’uso di mezzi più ecologici.
La seconda parte del Dossier è dedicata all’abitare. La riflessione parte da come la pandemia ha cambiato l’utilizzo degli spazi nelle abitazioni per pensare a come questi cambiamenti possono influire sulla nostra visione e progettazione dell’Abitare anche dopo la pandemia. Gli spazi attrezzati per lo smart working all’interno dell’abitazione, l’abitazione concepita non più come solo dormitorio, ma anche luogo di lavoro, di studio e di cultura, di svago e di socialità. La pandemia ha insegnato degli spazi aperti, dei balconi, terrazzi, cortili e giardini anche condominiali, tutti gli spazi intermedi in generale che possono svolgere ruoli importanti, anche dal punto di vista ambientale, con il green building approach. L’ emergenza coronavirus ha fatto anche ripensare all’importanza dello spazio urbano, ad una struttura urbanistica che assicuri prossimità delle residenze ai servizi, alle strutture lavorative e ricreative, così da ridurre gli spostamenti da una zona all’altra della città e i pendolarismi.

Presentata al Ces 2020 da Toyota, il prototipo di ecosistema urbano funzionerà totalmente ad idrogeno
Battezzata Woven City, la città del futuro progettata da Toyota sarà un ecosistema connesso e alimentato da idrogeno. La città sarà realizzata su un’area di oltre 70 ettari alla base del monte Fuji in Giappone. Presentata all'edizione 2020 del Ces di Las Vegas, è pensata come un laboratorio vivente dove residenti e ricercatori a tempo pieno testeranno e svilupperanno tecnologie innovative come l'autonomia, la robotica, veicoli a guida automatica, le case intelligenti e coltivazioni idroponiche. L'inaugurazione del sito è prevista per l'inizio del 2021.
“Costruire una città completa dalle fondamenta, anche su piccola scala come questa, è un'opportunità unica per sviluppare le tecnologie del futuro, compreso un sistema operativo digitale per le infrastrutture della città. Con persone, edifici e veicoli tutti collegati e in comunicazione tra loro attraverso dati e sensori, saremo in grado di testare l'intelligenza artificiale connessa... sia nel mondo virtuale che in quello fisico... massimizzandone il potenziale”, ha dichiarato Akio Toyoda, presidente della Toyota Motor Corporation.
Toyota estenderà un invito aperto di collaborazione ad altri partner commerciali e accademici ed esorterà gli scienziati e i ricercatori interessati di tutto il mondo a venire a lavorare ai propri progetti in questo incubatore, unico nel suo genere, nel mondo reale.
"Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono ispirati a migliorare il nostro modo di vivere nel futuro, a trarre vantaggio da questo ecosistema di ricerca unico nel suo genere e ad unirsi a noi nella nostra ricerca per creare uno stile di vita e una mobilità sempre migliore per tutti", afferma Akio Toyoda.
Per la progettazione di Woven City, Toyota ha incaricato l'architetto danese Bjarke Ingels, CEO di Bjarke Ingels Group (BIG).
"Uno sciame di tecnologie diverse sta cominciando a cambiare radicalmente il modo in cui abitiamo e viviamo le nostre città. Soluzioni di mobilità connesse, autonome, senza emissioni e condivise sono destinate a scatenare un mondo di opportunità per nuove forme di vita urbana. Con la portata delle tecnologie e dei settori a cui abbiamo potuto accedere e con cui abbiamo potuto collaborare grazie all'ecosistema aziendale Toyota, crediamo di avere con Woven City un'opportunità unica nell’esplorare nuove forme di urbanità che potrebbero aprire nuove strade da intraprendere per le altre città" afferma Bjarke Ingels.
La città è articolata su tre diverse tipologie di viabilità: quella riservata ai veicoli più veloci, quella dedicata a velocità inferiori come mobilità personale e pedoni ed infine percorsi assimilabili alle passeggiate nei parchi esclusivamente pedonali. I trasporti saranno tutti automatizzati e a zero emissioni.
Gli edifici saranno realizzati per o più in legno per ridurre al minimo le emissioni di CO2, utilizzando le tradizionali tecniche di falegnameria giapponese combinate a sistemi produttivi robotizzati. Grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici ubicati sui tetti degli edifici sarà possibile produrre energia solare oltre a quella generata dalle celle a combustibile a idrogeno. Le residenze saranno dotate delle più recenti tecnologie di domotica per assistere la vita quotidiana. Le case utilizzeranno l'intelligenza artificiale basata su sensori per controllare la salute degli occupanti, prendersi cura delle esigenze di base e migliorare la vita quotidiana, creando l'opportunità di utilizzare la tecnologia connessa con integrità e fiducia, in modo sicuro e positivo.
La città sarà immersa nel verde grazie alla presenza di vegetazione autoctona e idroponica.
Sottoterra, la città avrà un impianto di accumulo per l’idrogeno e uno per la filtrazione dell’acqua. Nel progetto è previsto anche un servizio di consegna diretta sotterraneo robotizzato. Una volta inaugurata, circa 2.000 persone saranno in grado di vivere nella Woven City, e Toyota ha già fatto sapere che darà la priorità ai propri ricercatori ma che aprirà anche spazi per pensionati, famiglie, rivenditori, scienziati e partner del settore.
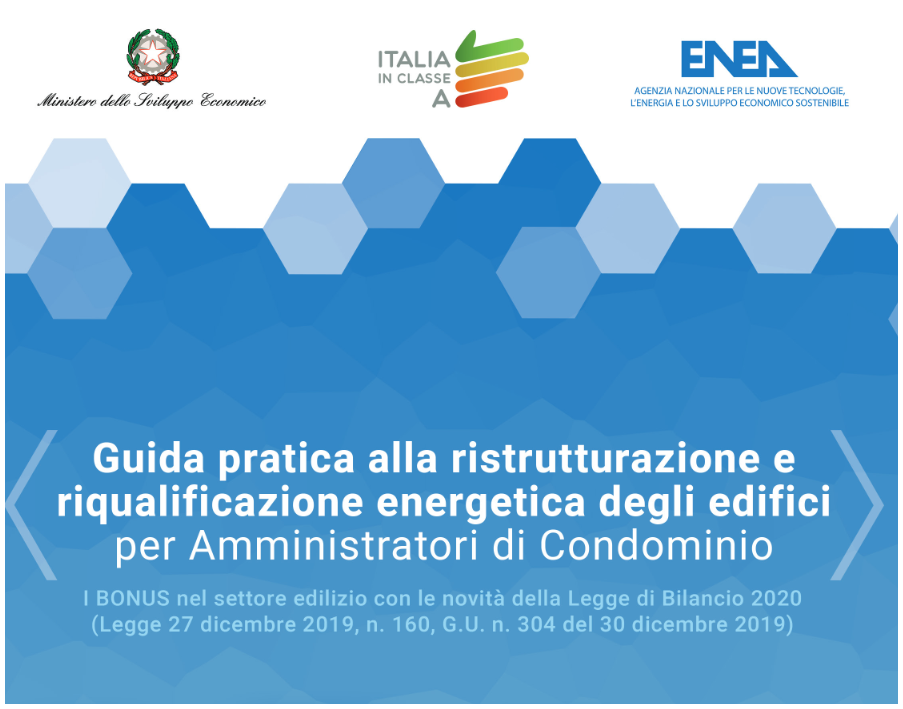
È online la Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per gli amministratori di condominio predisposta da ENEA e ISNOVA, realizzata nell’ambito della campagna nazionale "Italia in Classe A", finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA (ex art. 13 dgls 102/2014), per esporre in maniera pratica le azioni da intraprendere insieme alle procedure burocratiche da seguire che sono spesso poco chiare e dispersive.
“Questa guida intende presentare agli amministratori gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente”, evidenzia Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA.
Realizzato con linguaggio semplice, il manuale si articola in 5 capitoli con un allegato tecnico-normativo: energia e abitare; meccanismi d’incentivazione; esempi d’intervento; sensibilizzare l’assemblea dei condomini verso l’uso consapevole dell’energia; Condomini +4.0 ovvero l’app ENEA per la riqualificazione degli edifici. Indispensabile per gli amministratori di condominio e i professionisti del settore è il capitolo “Meccanismi d’incentivazione” dedicato alle detrazioni fiscali e agli incentivi che prende in considerazione la totalità delle più recenti novità normative e che, grazie al formato e-book, prevede l’aggiornamento automatico degli eventuali adeguamenti normativi e procedurali. Nell’e-book,inoltre, vengono riportati anche degli esempi pratici di intervento, con relativa scelta dei materiali, valutazione dei costi, detrazioni fiscali di cui poter beneficiare, informazioni tecniche e studio di fattibilità dell’intervento.
Per abbattere le diffidenze che ostacolano una più estesa diffusione della riqualificazione energetica nei condomini, nella guida si dedica un'attenzione particolare al “fattore umano”, ovvero al rapporto tra comportamenti, tecnologia e consumi di energia. “Circa il 40% dei consumi finali e il 36% delle emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case, uffici e negozi energivori, in quanto in gran parte costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’attenzione all’efficienza era minima. Per questa ragione la riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta una vera e propria miniera del risparmio energetico e favorisce la riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, un minore impatto ambientale e una concezione sostenibile dell’abitare, con un indiscusso miglioramento della qualità della vita” dichiara Ilaria Bertini.

Dal 2020 finanziamenti per i progetti di lotta al cambiamento climatico e mitigazione dei rischi
È stato approvato lo scorso 14 gennaio il Green New Deal, pacchetto finanziario lanciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il progetto per gli investimenti sostenibili proposto dalla Commissione lo scorso dicembre, dovrebbe fare dell’Europa un continente “verde” entro il 2050.
L’obiettivo è quello di dimezzare l’impatto inquinante europeo in dieci anni e azzerare le emissioni nette di CO2 in trenta. Per far ciò la Commissione guidata da Ursula von der Leyen proporrà una legge europea sul clima in modo tale da stimolare gli investimenti e fare in modo che il piano non resti un mero impegno politico.
La transazione verde interesserà diversi settori: la decarbonizzazione del settore energetico, la ristrutturazione degli edifici, la trasformazione dell’industria verso un processo di economia verde e la riduzione di emissioni derivanti dai trasporti.
Anche l'Italia, prepara un 2020 "verde" di riforme e investimenti. Già la Legge di Bilancio 2020, prevede l'istituzione di un fondo verde, per finanziare gli investimenti sostenibili. Inoltre ai Comuni saranno destinate risorse da spendere, a esempio, per l’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica, una mobilità non inquinante, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici.
La ministra della funzione pubblica, Fabiana Dadone, a tal proposito ha incontrato i ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico per definire la strategia che porterà, nei prossimi mesi, a norme più semplici.
"Energia, Sportello unico per le attività produttive, bonifiche, rifiuti e altri temi di grande rilievo: green new deal e sostenibilità hanno nelle semplificazioni normative e procedurali una precondizione essenziale" ha scritto la ministra in un post su Facebook.
Il presidente dell’Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) Gabriele Buia ha anch’egli ribadito l'importanza del piano verde nel panorama italiano:
"Nell'ultima legge di Bilancio il Governo ha dato un indirizzo ben preciso, ma abbiamo bisogno di misure attinenti al mondo delle costruzioni, a esempio, quelle sulla rigenerazione urbana, senza le quali non sarà mai possibile centrare l’obiettivo del Green Deal. Servono norme che ci permettano di intervenire sul tessuto edificato esistente perché solo così si possono ottemperare le condizioni richieste sia dall’Onu che dall’Europa. Su questo stiamo preparando un pacchetto di proposte per il legislatore che prevede una fase normativa e un grande supporto fiscale. Inoltre deve esserci più sensibilizzazione, una cultura dell’innovazione e del cambiamento".
Il Green New Deal rappresenta infatti una grande opportunità per la filiera delle costruzioni che rappresenta il 20 per cento del PIL, a patto che il legislatore fornisca i supporti senza i quali non è possibile essere operativi.
Il piano verde europeo e italiano rappresentano una sfida anche per il mondo della progettazione. Il vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanchini spiega quali potrebbero essere le opportunità le azioni per rendere sempre più sostenibili le città, gli edifici e la mobilità.
"Parigi, Barcellona, le grandi città europee stanno puntando a una mobilità sempre più incentrata sul trasporto pubblico elettrico - ha detto Zanchini nella video intervista - in Italia, tra il 2018 e il 2019, abbiamo costruito un chilometro di linee metro, è troppo poco. Il rilancio infrastrutturale del nostro Paese deve partire anche dalle città, tra l'altro nei prossimi mesi cominceremo a sperimentare le Comunità Energetiche e dovremo ripensare anche al patrimonio edilizio".
Legambiente ha pubblicato un dossier con una lista di 170 opere pubbliche che potrebbero essere finanziate con le risorse derivanti dal Green New Deal. A queste si aggiungono 11 emergenze climatiche: gli interventi riguarderebbero il miglioramento della sicurezza sismica e idrogeologica, la bonifica dei territori, innovazione nei trasporti e nelle infrastrutture, che consentirebbero agli italiani di vivere meglio.