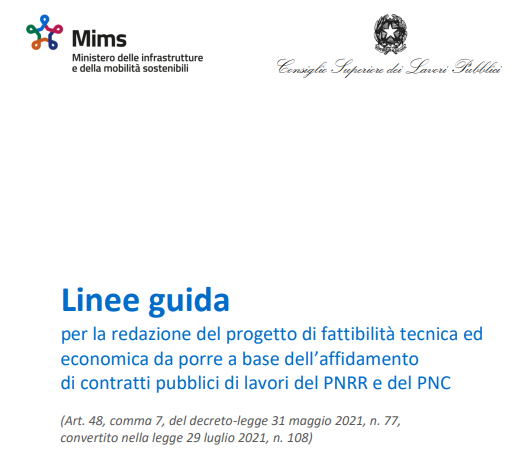Scia alternativa al permesso di costruire, interviene il TAR

Edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire. Uno degli maggiori limiti del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è probabilmente rappresentato dalla quantità di casistiche "limite" che interessati, tecnici e pubbliche amministrazione non riescono sempre ad incasellare all'interno del corretto articolo previsto dalla normativa edilizia.
Con la sentenza n. 1262 del 24 luglio 2021, il Tar Puglia interviene sulla validità della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione pesante, esaminando il ricorso per l’impugnazione e l’annullamento dell’ordinanza con cui era stata ingiunta la demolizione, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, di opere abusive consistenti in “tre muri perimetrali al piano superiore di un’abitazione preesistente di cui due misuranti 7,00 x 0,30 x h 1,90 ed uno di m. 7,00 x o,30 x h 1,20, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale”.
Secondo la ricorrente sarebbe stata sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire. Ma non per i Carabinieri locali che a seguito di sopralluogo hanno contestato la violazione di alcune norme edilizie procedendo al sequestro preventivo delle opere ritenute abusive con conseguente segnalazione al Comune che ha emesso l'ordinanza di demolizione ma (afferma il ricorrente) “senza alcuna adeguata istruttoria riportandosi pedissequamente a quanto accertato dai Carabinieri”. La ricorrente ha evidenziato che tali opere sarebbero state realizzate “sulla base di valido titolo abilitativo costituito da una Scia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di un fabbricato esistente ad uso abitativo, corredata dagli elaborati dimostranti il superamento dei vincoli presenti sull’immobile, nonché dalla relativa autorizzazione paesaggistica semplificata”, e nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia edilizia e sismica, supportate anche dal rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata. Quindi, tali opere non necessiterebbero “di autorizzazione sismica in quanto rientranti secondo la normativa nazionale sulle costruzioni, Ntc 018 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, tra le “opere di minore rilevanza” perché ricadenti, in particolare, “in sito di zonizzazione sismica 2 ma con ag minore di 0,20 g”.
Il Tar Puglia ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, analizzando l’ art. 23 del Dpr 380/2001, che individua una serie di interventi edilizi, tra i quali (comma 1, lett. a) “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela”. Dall’esame della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 gli elementi che connotano gli interventi di cd. “ristrutturazione pesante”, realizzabili tramite Scia alternativa a permesso di costruire, sono, tra gli altri, quelli che:
- non comportino la completa demolizione dell’edificio;
- comportino l’aumento del volume complessivo;
- apportino modifiche al prospetto dell’edificio;
- comportino un cambio d’uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso nel centro storico. Per tutti questi interventi è ammessa la Scia alternativa al permesso di costruire.
La medesima tabella prevede che il medesimo titolo è sufficiente per le nuove costruzione “in esecuzione di strumento urbanistico attuativo”, nonché per gli “interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati”, ivi compresi “gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi”.
Nel caso in esame, i lavori indicati nella Scia alternativa al permesso di costruire presentata dalla ricorrente fanno riferimento all’art. 4, comma 1 della Legge Regionale Puglia n. 14 del 2009 (cd. Piano casa), che all’art. 3 disciplina gli “interventi straordinari di ampliamento” stabilendo al primo comma che “possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3” , e ciò sul presupposto che “per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, ecc)”.
In sostanza, nel caso di specie gli interventi realizzati consistono in un ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile. Fatto che li riconduce di diritto agli interventi descritti alla lettera c), comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 380/2001, dato che gli interventi realizzati hanno evidentemente comportato (soltanto) “modifiche della volumetria complessiva” dell’edificio. Da ciò consegue che l’intervento edilizio trova legittimo titolo nella SCIA alternativa.
Inoltre, gli interventi realizzati rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b, n. 1 dell’art. 94 bis Tue, riferita agli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”: si tratta, in pratica, di interventi qualificabili come di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e, per tale ragione, esenti dal peculiare regime dell’autorizzazione sismica.
L’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l’ordine di demolizione delle opere considerate abusive, della Scia presentata dalla ricorrente, instaurando un contraddittorio finalizzato a stabilire le ragioni per le quali si sarebbe dovuto conseguire, quale titolo legittimante l’intervento, il permesso di costruire. In conclusione, il Tar ha accolto il ricorso.