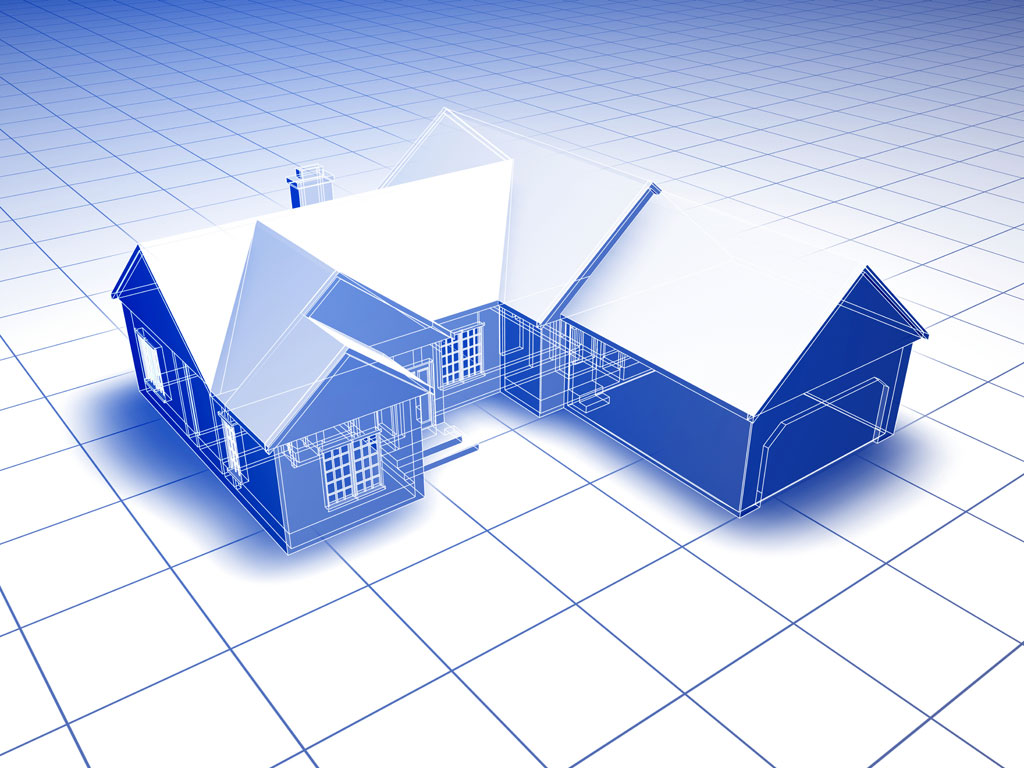Sul tema prendiamo spunto dalla Sentenza n.52977/2018 della Corte di Cassazione, con la quale ricorre il progettista e direttore dei lavori di un cantiere contro pronuncia della Corte d’Appello, oggetto di ricorso è l’errata applicazione dell’art.32 “Determinazione delle variazioni essenziali” del Testo Unico per l’Edilizia.
Il professionista trasmetteva al comune di ricadenza dell’immobile oggetto di opere richiesta ai fini dell’ottenimento del Permesso di Costruire in variante, seppure fosse necessaria l’istanza per l’ottenimento del nuovo titolo abilitativo edilizio considerando non la variante, bensì la variazione.
Sulla base del suo operato il tecnico contesta le risultanze della Corte d’Appello per aver modificato la sagoma del fabbricato eliminando una sporgenza triangolare, pertanto essendo essa variante in difetto, a suo giudizio non rientrerebbe nel regime delle “variazioni essenziali”. In particolare articola la sua tesi riconducendosi agli interventi di ristrutturazione edilizia, sostenendo il mutamento non possa rientrare tra i fattori tecnici per i quali occorra un autonomo Permesso di Costruire. Sulla base di ciò la Corte d’ Appello trae la logica conclusione le modifiche proposte dal tecnico non siano tali da poter rientrare nel concetto di variante, bensì in quello delle variazioni essenziali per le quali previsto conseguire un nuovo permesso di costruire, più concretamente la struttura edilizia risultava differente per una cubatura di mc.100,00, per sagoma e diversa allocazione rispetto al progetto autorizzato.
La Corte di Cassazione rilevando che, pure, la planimetria depositata in Comune con il progetto, rigettato, in variante, indicasse in modo errato la superficie del lotto ed, oltremodo, non rappresentasse le opere già realizzate in difformità al progetto originario, deduce le citate differenze si riscontrino anche nell’aver rappresentato il professionista una sagoma rettangolare, ovvero diversa in quanto priva della sporgenza triangolare, e di aver traslato il manufatto edilizio venendo meno anche al rispetto delle distanze legali.
È dalla superiore sentenza della Corte di Cassazione che si possono estrarre le tre interessanti definizioni sul concetto di variante al permesso di costruire, come distinte in varianti leggere o minori, varianti in senso proprio e variazioni essenziali:
Varianti leggere o minori: “ovvero quelle che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell'edificio (nonché rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire), per cui sono assoggettate alla mera denuncia di inizio attività, da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;”
Varianti in senso proprio: “consistenti in modificazioni qualitative o quantitative, seppure di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che non comportano cioè un sostanziale e radicale mutamento), le quali necessitano del rilascio del "permesso in variante", complementare ed accessorio rispetto all'originario permesso a costruire;”
Variazione essenziali “caratterizzate da "incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante”.
Sulle citate distinzioni sono molteplici le pronunce giurisprudenziali, tra queste cito il Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n.1484/2017, nella quale contraddistinte le varianti dalle variazioni essenziali, in un caso ove impugnati provvedimenti emessi dal Comune e della Sopraintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio e il Patrimonio Storico e Artistico e Etno-Antropologico.
Il ricorrente durante i lavori di sostituzione di una tettoia realizzava, senza autorizzazione, due lucernai al servizio degli appartamenti al piano ultimo del fabbricato, riceveva, pertanto, ordine di demolizione per le opere eseguite in difformità al progetto e alle prescrizioni tecniche comunali, ordine confermato prima dal Tribunale Amministrativo Regionale e dopo dal Consiglio di Stato.
Dalla sentenza si ricava testualmente: “il concetto di variazione essenziale attiene alle modalità di esecuzione delle opere, mentre le varianti riguardano la richiesta di variazione del titolo autorizzativo”, inoltre, è ribadito anche il concetto di variante e di variazione essenziale “le varianti, a loro volta, si distinguono in varianti essenziali e in modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello approvato, soggette al rilascio di un permesso in variante. Le varianti essenziali, sono caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario e sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario. Ai fini sanzionatori, in caso di variazioni essenziali è prevista la demolizione delle opere abusive”.
La variazione essenziale deve, pertanto, essere equiparata alla mancanza del permesso di costruire, pertanto alle difformità totali.
In tema di difformità parziale, invece, si ha riferimento giurisprudenziale dalla Sentenza n.55483/2018 della Corte di Cassazione, Sez. III, secondo cui l’astrazione debba riferirsi agli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, e le variazioni riguardare, invece, parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza.
Nel ricorso in oggetto il Tribunale ordinario eleva sanzione pecuniaria nei confronti dei ricorrenti ritenuti responsabili del reato di cui all’art.44 lettera a) del Testo Unico per l’edilizia, per avere realizzato maggiore cubatura, superficie e altezza di un edificio, in difformità dal Permesso di Costruire. L’importante contributo dal testo della sentenza de quò, da ricondursi alla esecuzione di interventi in parziale difformità, definisce quest’ultimo essere il concetto da attribuire alle circostanze nelle quali l’aumento del volume o della superficie sia di modesta entità, mentre la variazione essenziale si riscontra nelle medesime modifiche laddove interessanti parti accessorie di non specifica rilevanza.
Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita