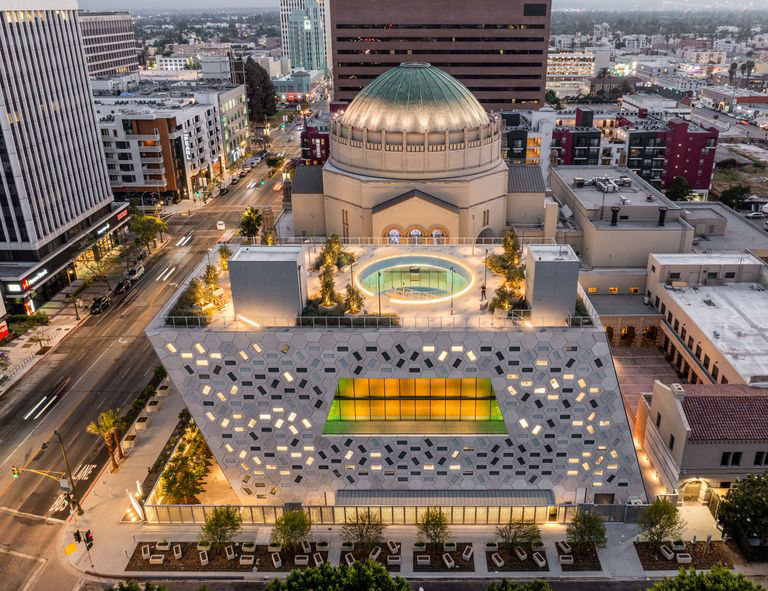Arx Vivendi, un progetto tra memoria ed accoglienza

Un monastero del XVII sec. sul Lago di Garda viene riconvertito a struttura ricettiva all’insegna del benessere e della meditazione.
Il progetto condotto dal team di noa network of architecture trasforma infatti l’antico monastero delle Serve di Maria Addolorata della città di Arco edificato da Leopoldo d’Austria, sottoposto a vincolo, secondo una linea di intervento che asseconda le tracce del passato. Parte dell’edificio, con le sue alte mura ed il suo giardino interno, ha mantenuto la sua antica funzione di luogo di clausura, così come resta l’antica chiesa. Ci si è concentrati infatti sull’ala Ovest, i lavori si sono conclusi nell’arco di circa un anno con il contributo della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento. Uno dei connotati principali della struttura, ovvero il suo rigore formale diventa punto di forza e di partenza ai fini progettuali, come racconta l’architetto Francesco Padovan, del team noa*:
“La grandiosità e il rigore delle architetture, i lunghi corridoi, i soffitti a volta, tutto concorre a dare a questi spazi un carattere fuori dal tempo. Una filosofia progettuale che ci ha guidato e aiutato a mantenere la chiarezza compositiva, statica e visiva, che rende il monastero un luogo davvero speciale".
Emerge una spiccata attenzione al dettaglio, alla scelta di colori e materiali da impiegare, al mantenimento dei percorsi originari e alla volontà di adeguare a tali criteri i nuovi volumi. La struttura, dunque, offre 37 camere standard, 3 suites ed un’area wellness realizzata ex novo ispirata alla ruralità del territorio. Le strutture vetrate dell’area, infatti, corroborano il rapporto fra la storia antica del monastero con quella del paesaggio rurale che lo circonda. Il carattere spirituale della struttura ben si sposa con l’offerta ricettiva predisposta, aggiunge infatti Padovan:
“È un rifugio capace di offrire esperienze antiche, valorizzando al massimo la particolarità e la storia del luogo. Dove ogni scelta costruttiva, ogni materiale e dettaglio sono stati studiati per trarre forza dalla monumentalità del contesto preesistente, esaltandola e portandola a nuova vita.”
I tre livelli del monastero presentano una differente configurazione interna, in particolare al piano terra si sono voluti valorizzare i percorsi esistenti, dunque la reception, la sala colazione e una sala lettura si susseguono linearmente lungo i corridoi voltati a crociere; sullo stesso corridoio affacciano il bar ed una cucina. Infine, al piano terra è presenta un delle tre suites, dotata di un giardino privata a disposizione degli ospiti.
Il primo piano è connotato dalle travi lignee che corrono lungo il corridoio centrale, dove trovano posto le altre camere, ricavate dalla fusione delle celle monastiche. Anche al secondo piano, il sottotetto, sono state restaurate le capriate di copertura e ricavate ulteriori stanze.
"Si va dagli spazi concentrici del piano terra al maestoso corridoio del primo piano, alla selva di travi lignee del sottotetto. Su questa varietà di ambienti abbiamo lavorato, definendo soluzioni che non alterassero i diversi disegni, ma ne restituissero rafforzati il fascino e l’originalità".
A completamento dell’opera una grande importanza ha rivestito il progetto degli arredi che vede scelte mirate, su misura, con l’impiego delle tonalità del bianco, del grigio e del nero e sfrutta i soffitti ed i decori esistenti, conservati e restaurati. Come afferma l’interior designer del gruppo di progettazione, Niccolò Panzani:
"La cura del dettaglio, il disegno su misura, ci consentono di offrire un progetto sempre unico, esclusivo, mai ripetitivo, creato ad hoc per il committente, ma qui, l’eccezionalità del luogo ha ulteriormente plasmato le nostre scelte, per restituire quel senso di pace e di tranquillità che il monastero ha custodito per secoli”.