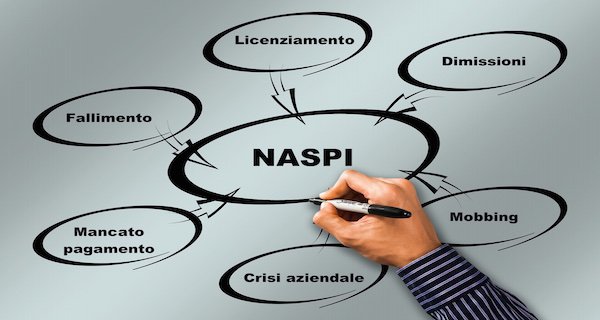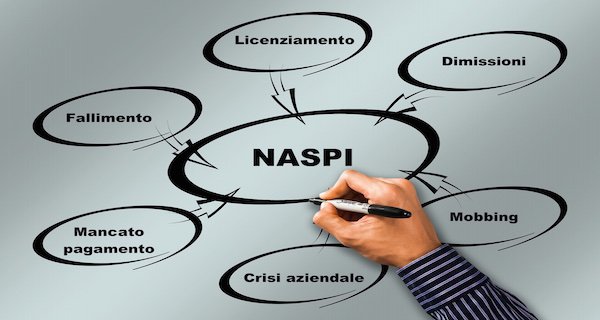
La NASPI è un'indennità mensile di disoccupazione spettante ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, a chi subisce un licenziamento, a chi scade il contratto a tempo determinato, a coloro i quali presentano dimissioni per giusta causa ed alle neo mamme che si dimettono nel primo anno di vita del bambino.
Essa viene erogata su domanda dell’interessato.
La NASPI, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione AspI e MiniASpI, è stata introdotta dall'art. 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Tale indennità può essere richiesta qualora il rapporto di lavoro subordinato sia cessato involontariamente e si abbiano almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione.
Oltre ai dipendenti privati, a tempo determinato o indeterminato, l'indennità in questione spetta anche ai seguenti soggetti:
- i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con contratto di lavoro subordinato.
Non possono, invece, godere della NASPI:
- gli operai agricoli;
- i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Inoltre, la NASPI non spetta a coloro che presentano dimissioni volontarie, dal momento che la perdita del rapporto di lavoro, come già specificato, non è involontaria; dunque, chi lascia liberamente il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Tuttavia, si ha diritto alla Naspi in caso di dimissioni per giusta causa, le quali si verificano nel caso in cui il lavoratore recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro a causa di un comportamento gravemente inadempiente del datore di lavoro che non gli permette la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
I comportamenti del datore di lavoro che possono giustificare le dimissioni per giusta causa sono i seguenti:
- mobbing;
- omesso pagamento della retribuzione;
- modificazioni che peggiorano le mansioni di lavoro;
- modificazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda o di un ramo di essa;
- trasferimento in un’altra sede di lavoro in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

L’associazione in partecipazione altro non è che una forma particolare di contratto con cui un imprenditore (l’associante) si accorda con uno o più soggetti (associati), i quali si impegnano a fornire la loro attività lavorativa all’interno dell’impresa, ricevendo la partecipazione agli utili dell’impresa quale compenso.
Il numero degli associati impegnati in una stessa attività non può essere superiore a tre, salvo il caso in cui siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo o laddove l’associato sia un’impresa.
Il lavoro subordinato, detto anche lavoro dipendente, indica un rapporto di lavoro in cui il lavoratore cede il proprio lavoro ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione.
Il d.lgs. 276/2003 sancisce che “La mancanza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o la mancata consegna del rendiconto, presume salvo prova contraria, l’esistenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prevede che il lavoratore abbia diritto ai trattamenti retributivi, contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo”.
Affinché si configuri un contratto di associazione in partecipazione piuttosto che di lavoro subordinato, l’associato deve essere coinvolto direttamente nella gestione e nell’andamento dell’impresa, ovvero deve partecipare sia alla distribuzione degli utili che alle perdite, e, in ogni caso, ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se quest’ultima si protrae per più di un anno.
Infine, per ben comprendere la differenza intercorrente fra associazione in partecipazione e lavoro subordinato, è opportuno menzionare una pronuncia della Cassazione, secondo cui “L’elemento che contraddistingue l’associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa dal contratto subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa non risiede nel nomen iuris utilizzato dalla parti, ma nel contesto in cui si svolge la prestazione da parte dell’associato. Pertanto, è opinione di questa Suprema Corte che laddove il lavoro dell’associato in partecipazione venga reso senza alcun rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione aziendale, il rapporto si configura in realtà come un contratto di natura subordinata” (Cass., sent. n. 2015 del 4 febbraio 2015).
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17051 del 16 giugno 2021, ha affermato che, per la determinazione del quantum dovuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il reddito percepito dopo il licenziamento va detratto qualora risulti compatibile con l’attività espletata prima del licenziamento.
Nella vicenda in esame, il giudice di merito aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore ed aveva rigettato l’eccezione sollevata dal datore di lavoro volta ad ottenere la riduzione dell’ammontare del danno risarcibile in ragione della richiesta detrazione di quanto percepito dal dipendente (aliunde perceptum) in epoca successiva al licenziamento. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che la prestazione di lavoro resa dopo il licenziamento non fosse incompatibile con quella svolta prima dello stesso sicché il relativo compenso non andava detratto ai fini della quantificazione del danno.
Per il Tribunale Supremo, “in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo - che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cd. periodo intermedio) - non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se - e nei limiti in cui - quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento (come nel caso ricorrente nella specie in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che risulti sospesa)”.
Tra l’altro, spetta al datore di lavoro che sollevi l’eccezione provare che il dipendente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito.
Pertanto, in virtù dei suddetti principi, i giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

Con la sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del dipendente che svolge altra attività ricreativa nel corso del periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Nella vicenda in esame, una società datrice di lavoro impugnava la sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore, il quale, durante il periodo di assenza per malattia, aveva svolto attività incompatibili con il suo stato di salute (sindrome ansioso depressiva).
I giudici di merito rigettavano il ricorso, non riscontrando la violazione del principio di correttezza e buona fede, e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, che caratterizzano ogni contratto di lavoro.
La società datrice si rivolgeva così alla Corte di Cassazione, che confermava l’orientamento della Corte d’Appello e, dunque, rigettava il ricorso.
In particolare, il Tribunale Supremo sottolineava che “anche alla stregua dei concetto di malattia desumibile dall’art.32 della Costituzione, la patologia impeditiva considerata dall’art. 2110 Cod. Civile (…), va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova; dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa; la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione; e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico – fisiche. Restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito; all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante”.
Per gli Ermellini, lo stato di malattia del lavoratore non impedisce, in ogni caso, la possibilità di svolgere attività con esso compatibili (lavorative o ricreative), pertanto, in tali casi, il licenziamento disciplinare è infondato e illegittimo.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'

È legittimo l’arresto in flagranza del datore di lavoro che approfitta dello stato di bisogno dei suoi dipendenti, qualora venga provata tale condizione di difficoltà degli stessi.
Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28735 del 23 luglio 2021.
Nella vicenda in esame, il Tribunale non convalidava l'arresto in flagranza di reato di dell’imprenditore Tizio in ordine al reato di cui all'art. 603 comma 1 n. 3) comma 3 n. 1) e 3) cod. pen. per avere impiegato alcuni lavoratori approfittando del loro stato di bisogno, attraverso reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dalle previsioni contrattuali e comunque sproporzionate, nonché con violazione di norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, con l'aggravante di averli esposti a pericolo per la loro incolumità.
Il giudice riteneva non emergere l’inadeguatezza palese del profilo retributivo ed escludeva che le inosservanze normative di carattere amministrativo, pure ascrivibili al datore di lavoro, potessero ridondare in illecito penale tenuto anche conto che, dal punto di vista amministrativo e formale, l'attività commerciale non risultava neppure avviata.
Contro il provvedimento di mancata convalida proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina normativa in esame, evidenziando come la condizione del bisogno di alcuni dipendenti era dimostrata dalla clandestinità, che il trattamento economico risultava palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro e che l’irregolarità amministrativa in cui versava l’azienda di Tizio non poteva costituire ragione di esonero dagli obblighi di sicurezza e di prevenzione comunque gravanti sul datore di lavoro, quali la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi e la nomina di un responsabile della sicurezza sul lavoro.
Depositava memoria difensiva la difesa dell'indagato, il quale rilevava la correttezza del ragionamento del giudice della convalida, valorizzando gli elementi riguardanti la natura e le caratteristiche dei rapporti di lavoro, idonei a contrastare la prospettazione accusatoria.
Gli Ermellini stabilivano che l’arresto del datore di lavoro che sfrutti lo stato di bisogno dei lavoratori risulta legittimo qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza.
Secondo i giudici di legittimità sono elementi che sottendono lo stato di bisogno dei lavoratori:
• la clandestinità;
• il riconoscimento di un trattamento economico palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro;
• l’omissione dei necessari obblighi antinfortunistici.
Pertanto, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso del Procuratore Generale e convalidava l’arresto in flagranza di Tizio.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'