La cessione d'azienda occulta
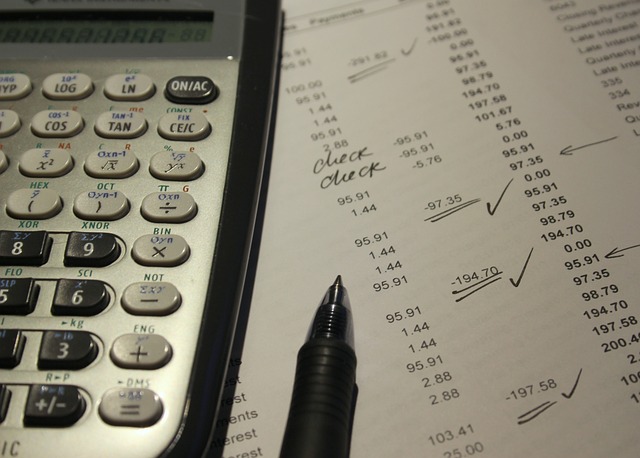
Sempre più spesso ci capita di ricevere clienti portatori di ingenti crediti nei confronti di attività imprenditoriali le quali, al momento del tentativo di riscossione, risultano improvvisamente dileguate nel nulla oltrechè, ovviamente, in stato di liquidazione, se non già definitivamente cancellate dalle Camere di Commercio di competenza. Nella maggior parte dei casi, vuoi per la particolare scaltrezza dell’imprenditore fedifrago, vuoi per il fatto che l’impresa (purtroppo, e succede spesso) ha effettivamente chiuso i battenti per non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, il credito va considerato come elargito in beneficienza ovvero, nella migliore delle ipotesi, “messo a perdita” ai sensi della vigente normativa fiscale. Non sempre, però, tutto è perduto. Può capitare infatti, ed anzi, capita frequentemente, che l’imprenditore-debitore ritenga di poter sfruttare la limitazione di responsabilità giuridica della propria organizzazione societaria, abbandonandola, affogata di debiti, al proprio destino, per poi risorgere, come fenice dalla cenere, sotto altro nome (sempre societario) ma svolgendo, impunemente, praticamente e senza soluzione di continuità, la stessa attività della prima, senza neanche subire il disposto dell’art.2560, II° co., c.c., così fastidiosamente incidente sul trasferimento dei debiti da azienda cedente ad azienda ceduta. La cospicua frequenza, come detto, di dette operazioni, e la conseguente ripetitività di azioni giudiziarie volte all’accertamento della sottostante operazione disonesta, hanno portato alla creazione della figura giurisprudenziale della “cessione d’azienda occulta”, secondo la quale, qui in estrema sintesi, laddove si riscontri, secondo i criteri che vedremo, una sostanziale identità, ovvero, un fattuale trasferimento d’azienda tra una società ed un'altra, la seconda potrà essere ritenuta giudizialmente responsabile dei debiti della prima. Analizzando infatti i numerosi casi concreti verificatisi, ci si accorge della sussistenza in tutti della stessa, ricorrente ed inequivocabile circostanza che il “secondo” (medesimo) imprenditore, vuoi per questioni affettive, vuoi, verosimilmente, per necessità di gestione dell’attività commerciale, non riesce mai a staccarsi completamente dalla prima azienda, se non facendo una blanda operazione di camouflage e dunque, esaminando le visure camerali delle due società riscontreremo: le stesse partecipazioni societarie, se seppure per quote diverse, e con aggiunta di nuovi soggetti; un identico oggetto sociale; una molto simile denominazione sociale; sede principale, o secondarie, immutate / scambiate .. etc.. Esaustivamente dirimente, sul punto, una sentenza del Tribunale di Treviso del 30 novembre 2018 n. 2395, tuttora immutata ed incontrastata, la quale, con ampia ed esauriente motivazione, ha rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo concesso in favore di un creditore di fatto subentrato nell’esercizio dell’azienda gestita da una -dissimulata- cedente, qui sostenendo la tesi della cessione occulta d’azienda e stabilendo che detta cessione occulta può essere provata dal creditore tramite presunzioni semplici, seppure gravi, precise e concordanti, chiaramente identificando e classificando le più rilevanti, quali, ad esempio:
- l’identità della ditta;
- l’identità della sede;
- l’esercizio di attività sostanzialmente similare;
- l’utilizzo di medesimi/simili recapiti e di domìni internet, tutti facilmente riconducibili alla “cedente”.
Insomma, così come nei più classici dei romanzi gialli, l’assassino torna sempre sulla scena del delitto, così l’imprenditore/debitore-cedente/ceduto torna, anzi non va mai via, dalla propria comfort-zone d’impresa. Ed è proprio lì che, se si vuole tentare di recuperare un credito ritenuto perso, bisogna andare a cercare.
